Pubblichiamo, perché d'interesse, il documento dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale ritiene che la legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata definitivamente il 30 ottobre 2025, tenda ad una più coerente e concreta attuazione del «giusto» processo penale, così come delineato dall’art. 111 Cost. Si tratta di una valutazione di sintesi che non pretende di esprimersi su ogni aspetto della riforma e che non tocca, come si conviene alla disamina su basi scientifiche, né la questione di carattere politico riguardante lo spazio riservato alla dialettica parlamentare nel procedimento di revisione costituzionale, né le polemiche di schieramento circa gli scenari suscettibili di prodursi in un ipotetico futuro (la paventata attrazione dell’organo dell’accusa nell’orbita del governo).
Pur nella consapevolezza di opinioni non sempre convergenti, qui si coglie il contributo positivo che la riforma può produrre sulla cruciale esigenza di imparzialità del giudice, posta (non tanto tra gli altri canoni del modello, bensì) «al vertice dei valori del “giusto processo”» poiché «in sua carenza tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di significato» (Corte cost., sent. n. 306 del 1997).
In questa vitale materia va riconosciuta l’evoluzione di cui si è resa prima artefice la cultura giuridico-processuale, di pari passo con il maturarsi della coscienza sociale. Se, sotto il codice d’epoca fascista, era considerato accettabile persino l’accorpamento in un’unica figura (il Pretore) della duplice funzione requirente e giudicante, visto che il pubblico ministero esercitava poteri istruttori e limitativi della libertà non dissimili da quelli attribuiti al giudice, il passaggio epocale al processo penale di stampo accusatorio ha determinato la necessità di collocare il pubblico ministero in quel ruolo di parte che «meglio si addice al processo di una moderna democrazia, dove si postula il principio di parità tra accusa e difesa» (così, alla vigilia del “nuovo” codice di rito, Corte cost., sent. n. 268 del 1986). Ebbene, la svolta codicistica del 1987-’89 rappresenta il frutto genuino – merita ricordarlo – delle intuizioni, dell’impegno e della elaborazione scientifica condotta dagli studiosi del processo penale, fin dagli anni ‘60. Tuttavia, a tale riforma mancò l’ulteriore passo, in sintonia con la rinnovata struttura processuale, volto a disgiungere il pubblico ministero dal giudice sul piano della organizzazione giudiziaria; così come sfumò, all’indomani della revisione costituzionale sul «giusto processo», l’occasione di introdurre una più rigorosa tutela della «terzietà» ordinamentale dell’organo giudicante, che pure venne preconizzata nei lavori di stesura dell’odierno art. 111 comma 2 Cost.
Tale tutela deve mostrarsi all’altezza di un principio, quello di imparzialità, da cui dipende – si è sopra rammentato con le parole della Corte costituzionale – l’essenza stessa del «giusto» processo, tanto più quando la fisionomia di quest’ultimo sia improntata al contraddittorio nella formazione della prova.
E’ conveniente che un risultato di simile levatura non resti affidato alle sole qualità personali del giudice, alla distinzione di funzioni nella dinamica del processo tra magistrato requirente e magistrato giudicante, ai rimedi contro eventuali incompatibilità, ai limiti più o meno stretti di passaggio di un medesimo magistrato-persona dall’uno all’altro ruolo durante il proprio percorso professionale. Bisogna considerare quale importanza rivestano in questo settore le stesse apparenze, indipendentemente da ciò che è: la questione se il giudice offra garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio presso i consociati quanto alla sua imparzialità (Corte EDU, 15 ottobre 2009, Micaleff c. Malta). Non sembra dunque trascurabile il compito di spingersi fino alla soglia più elevata possibile, consentita dagli strumenti di fonte legale (sia processuale, sia di ordinamento giudiziario), nel tentativo di rimuovere le situazioni che sono o appaiono di ostacolo ad un esercizio effettivamente neutro della giurisdizione, capace di assicurare effettività alle garanzie della difesa, del contraddittorio, delle libertà fondamentali; di evitare cioè il rischio che il giudice inclini pregiudizialmente verso le istanze dell’accusa, le quali, sia pure di natura pubblicistica, non possono nello Stato di diritto godere di preminente favore rispetto a quelle dell’imputato presunto innocente.
Nel senso appena precisato, non sembra dubbio che il massimo risultato conseguibile all’interno di un sistema che voglia mantenere fermo l’assetto burocratico della magistratura, passi anche per la separazione della organizzazione istituzionale tra giudicanti e requirenti, così da evitare (anche solo il sospetto) che la solidarietà nascente dalla condivisione di vedute, interessi, prospettive di carriera in seno al corpo unitario, gestito da un comune organo di governo autonomo, possa far velo alla necessaria equidistanza del giudice rispetto ad entrambe le parti processuali.
Del resto, bisogna ricordare alcune tra le principali storture che la concezione unitaria della magistratura – con il corollario della pretesa “imparzialità” del pubblico ministero, condensata nell’ossimoro “parte imparziale” e, per questo, della sua sostanziale assimilazione alla figura del giudice ha storicamente concorso a determinare in ambito processuale: dal riconoscimento di pieno valore probatorio agli atti d’indagine raccolti dal magistrato inquirente, causa del fallimento della riforma processuale accusatoria (Corte cost., nn. 254 e 255 del 1992); alla pretesa che fosse soltanto quest’ultimo, nell’interesse generale, a fungere da collettore delle conoscenze a vantaggio della difesa durante la fase preliminare (teoria della “canalizzazione”, secondo Cass., 18 agosto 1992, Burrafato); sino al maggior credito tributato alla consulenza tecnica del pubblico ministero, in quanto l’esperto nominato dall’accusa è ausiliario di un organo che – si dice – svolge «attività di natura giurisdizionale» e «non è portatore di interessi di parte» (Cass., 18 febbraio 2020, Barbone).
Per questo complesso di ragioni merita adeguata considerazione l’obiettivo avuto di mira dalla legge costituzionale recentemente approvata, di distinguere dal lato ordinamentale i giudici dai magistrati destinati al ruolo di pubblico ministero e di rimodellare, di conseguenza, l’assetto del sistema di autogoverno.
Si auspica infine che, in caso di conferma tramite il referendum popolare previsto dalla Carta fondamentale, le norme di attuazione della legge costituzionale in questione regolino i percorsi di formazione (sia per l’accesso al concorso, sia permanenti) di entrambe le categorie di magistrati, in modo da consentire che patrimonio comune tanto ai giudici quanto ai pubblici ministeri, al di là dello status e della funzione distinta, sia la piena consapevolezza circa la necessità di rispettare i principi di legalità penale e processuale, risultato raggiungibile – tra l’altro – attraverso un più ampio ed effettivo
coinvolgimento della componente accademica nella pluralità dei suoi indirizzi ideali, culturali e
metodologici.
Il Direttivo dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale G. D. Pisapia: professori Adolfo Scalfati, Sergio Lorusso, Giulio Garuti, Filippo Dinacci, Mariangela Montagna, Daniele Negri, con voto contrario del prof. Michele Caianiello.









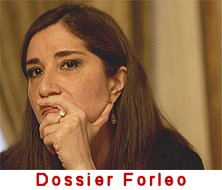














0 commenti:
Posta un commento