di Giuliano Castiglia
Magistrato
Il Parlamento ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge costituzionale della c.d. “riforma della giustizia”.
In assenza della maggioranza dei due terzi, Parlamentari pro e contro ne hanno separatamente promosso la sottoposizione a Referendum, che si terrà nei prossimi mesi.
Uno degli aspetti più criticati dagli oppositori della Riforma è l’istituzione di un nuovo organo, l’Alta Corte, alla quale viene attribuita «la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari».
Vengono criticati, in particolare, il carattere di giudice speciale dell’Alta Corte, l’impugnabilità delle sue decisioni dinanzi a sé stessa e l’assenza di una disciplina costituzionale che assicuri la maggioranza togata nei collegi giudicanti.
Si tratta, effettivamente, di uno snodo delicatissimo dell’ordinamento giudiziario e la previsione di un giudice speciale, competente sia in primo che in secondo grado, non può non destare perplessità.
Il giudizio su una qualunque riforma, tuttavia, non può mai essere assoluto. Deve essere, invece, comparativo, mettendo a confronto l’assetto vigente con l’assetto che verrebbe fuori dalla riforma.
Il sistema disciplinare imperniato sull’Alta Corte, dunque, va confrontato col sistema attualmente vigente.
È ovvio che, al momento, è possibile solo un confronto provvisorio perché si ha a disposizione solo il potenziale testo riformato e non anche, ovviamente, le leggi che dovranno dare attuazione, in caso di superamento del Referendum, alle nuove previsioni costituzionali.
Ciò premesso, la giurisdizione disciplinare è oggi attribuita dalla legge alla Sezione disciplinare del CSM.
Si tratta di un giudice speciale, non previsto dalla Costituzione.
La Sezione disciplinare è un giudice elettivo. È composta, infatti, da alcuni tra i componenti eletti del CSM.
È presieduta dal Vicepresidente del CSM, il quale è eletto dallo stesso CSM tra i componenti eletti dal Parlamento: un laico, dunque, non un magistrato.
Tutti i giudici della Sezione disciplinare, quindi, sono membri dell’organo di amministrazione dei magistrati, il Consiglio Superiore della Magistratura. In definitiva, coloro che giudicano disciplinarmente i magistrati sono una parte di coloro che li amministrano.
È palese, dunque, la compromissione del carattere di terzietà e imparzialità nell’attuale giudice disciplinare dei magistrati.
Se poi fosse vero, come oggi finiscono col sostenere gli oppositori della Riforma, che il CSM è un organo politico con componenti titolari di una rappresentanza degli elettori, l’odierno giudice disciplinare dei magistrati sarebbe anche un giudice politico. Ma, per fortuna, almeno formalmente, questo non è vero.
La Sezione disciplinare è un giudice in unico grado di merito.
Le sue sentenze non sono appellabili. Sono soggette soltanto a ricorso per cassazione per motivi di legittimità.
La composizione della Sezione disciplinare, la sua articolazione interna e la formazione dei collegi giudicanti non sono in alcun modo disciplinate dalla Costituzione.
E non potrebbe essere diversamente, trattandosi di un giudice speciale non previsto dalla Costituzione e “inventato” di sana pianta dal legislatore ordinario.
La maggioranza togata nei collegi giudicanti della Sezione disciplinare, dunque, è priva di qualunque copertura costituzionale.
La questione è resa macroscopicamente evidente dalla totale assenza, nella Sezione disciplinare, della componente di diritto del CSM: Presidente della Repubblica, Presidente della Corte di cassazione e Procuratore generale presso la stessa, che sono i componenti di diritto del CSM, sono estranei alla Sezione disciplinare. Il Procuratore generale, da componente del CSM, si trasforma in accusatore dinanzi alla Sezione disciplinare e il Presidente della Cassazione presiede l’organo dinanzi al quale, per soli motivi di legittimità, possono essere impugnate le sentenze della Sezione disciplinare. Chi presiede l’organo di impugnazione delle pronunce della Sezione disciplinare, dunque, è componente del CSM (nonché del Comitato di presidenza dello stesso).
Quanto al Presidente della Repubblica, pur essendo Presidente del CSM, lo stesso non mette parola nella materia disciplinare.
Dopo decenni in cui il problema è passato in cavalleria, le denunce di tale macroscopica anomalia da parte di pochi eretici hanno fatto sì che oggi si assista a molteplici astensioni del Presidente della Corte di cassazione e del Procuratore generale presso la stessa in casi che hanno profili di connessione con potenziali vicende disciplinari, soprattutto nelle pratiche di trasferimento per c.d. “incompatibilità ambientale”, con l’assurda conseguenza che il Consiglio resta privato dell’apporto della sua componente di diritto non solo nell’assunzione delle decisioni disciplinari ma anche nell’esercizio della sua funzione prettamente amministrativa.
Passiamo alla considerazione dell’Alta Corte.
Anch’essa, come detto, sarebbe un giudice speciale.
Con l’espressa previsione in Costituzione, tuttavia, verrebbe meno il macroscopico contrasto con il divieto costituzionale di istituire giudici speciali (art. 102, co. 2°), che oggi caratterizza, invece, la Sezione disciplinare del CSM.
Quanto alla composizione, tre quinti sono magistrati, selezionati mediante sorteggio, un quinto sono nominati dal Presidente della Repubblica e un quinto sono sorteggiati da un elenco di eletti dal Parlamento.
Non si tratterebbe, quindi, di un giudice elettivo: l’elezione, infatti, concorrerebbe al procedimento di selezione solo di una minima parte dei componenti dell’Alta Corte, ossia il quinto sorteggiato da un elenco formato, mediante elezione appunto, dal Parlamento in seduta comune.
L’Alta Corte è conformata come organo prettamente giurisdizionale, in toto distinto dagli organi di amministrazione dei magistrati. Sotto questo profilo, quindi, non appare soffrire quel deficit di terzietà e imparzialità che oggi contrassegna, invece, la Sezione disciplinare né determina quegli inconvenienti che oggi inducono il Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la stessa a frequenti astensioni nella trattazione delle pratiche amministrative di competenza del CSM.
Quanto all’impugnabilità delle sue pronunce, il testo del riformato art. 105 della Costituzione, al comma 7°, prevederebbe che «contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte».
Senza dubbio, quindi, ancorché dinanzi allo stesso organo giurisdizionale, ai magistrati sono assicurati due gradi di merito.
Quanto alla possibilità di ricorso per Cassazione, l’avverbio «soltanto» che contrassegna la previsione appena richiamata potrebbe indurre a pensare che esso non sia consentito.
Tuttavia, l’art. 111, comma 7°, della Costituzione continua a prevedere che «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge» e il comma 8° dello stesso articolo limita il ricorso per cassazione ai soli motivi di giurisdizione soltanto per le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, senza nulla prevedere per quelle dell’Alta Corte disciplinare.
La corretta lettura sistematica delle disposizioni in questione, allora, appare quella secondo cui le decisioni dell’Alta Corte saranno impugnabili dinanzi alla stessa Alta Corte qualora venga censurato solo o anche il merito della decisione mentre saranno impugnabili con ricorso per cassazione in caso di censure di sola legittimità.
In tal senso, oltre all’immutata previsione dell’art. 111, comma 7°, Cost., militano sia la previsione del nuovo articolo 105, comma 7°, che limita l’impugnabilità delle decisioni dell’Alta Corte «soltanto» dinanzi alla stessa Alta Corte allorquando l’impugnazione venga proposta «anche per motivi di merito», sia quella del comma 8° dell’art. 111 Cost., che limita la possibilità di ricorso per cassazione alle sole questioni di giurisdizione soltanto avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti senza nulla dire, invece, per le sentenze dell’Alta Corte, nell’ovvio presupposto che le stesse sono soggette all’ordinario regime di impugnabilità con ricorso in cassazione, per motivi di legittimità, previsto dal settimo comma dell’art. 111.
Ulteriore conferma in questo senso deriva dal duplice rilievo che, da un lato, mentre l’art. 105 è norma relativa all’ordinamento giurisdizionale, l’art. 111 è norma relativa alla giurisdizione e, in particolare, al giusto processo; dall’altro, che il ricorso in Cassazione per motivi di legittimità è un contrassegno del giusto processo costituzionale ed escluderne la possibilità soltanto per le sentenze attinenti alla disciplina dei magistrati, senza neppure prevedere che tali sentenze possano essere impugnate in Cassazione per motivi di giurisdizione, si porrebbe macroscopicamente in contrasto, oltre che con i principi del giusto processo, con il fondamentale principio di uguaglianza.
Quindi, riassumendo, la Sezione disciplinare del CSM, cui oggi compete la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati, è un giudice speciale non previsto dalla Costituzione, elettivo, fortemente compromesso sul piano dell’imparzialità e terzietà, la cui composizione e articolazione non trova in Costituzione alcuna regolamentazione e di unico grado di merito, ossia competente ad adottare decisioni inappellabili ma soggette soltanto a ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.
L’Alta Corte, cui competerebbe la giurisdizione disciplinare se la Riforma superasse l’esame referendario, sarebbe un giudice speciale previsto dalla Costituzione, fondamentalmente non elettivo, pienamente terzo e imparziale, la cui composizione troverebbe in Costituzione le sue regole fondamentali e di duplice grado di merito, ossia competente ad adottare decisioni appellabili dinanzi a se stessa e ricorribili in Cassazione per motivi di legittimità.
Conclusivamente, per quanto l’Alta Corte desti non poche perplessità, nel confronto con l’attuale assetto, il bilancio complessivo sembra pendere a suo favore.
O quantomeno, con riferimento ai tre profili sui quali si appunta principalmente la critica dei detrattori della Riforma, l’Alta Corte si fa sicuramente preferire all’oggi operante Sezione disciplinare del CSM:
1) l’Alta Corte è un giudice speciale ma anche la Sezione disciplinare del CSM è un giudice speciale;
2) la maggioranza togata nei collegi dell’Alta Corte non ha espressa copertura costituzionale ma ancor meno ce l’ha in quelli della Sezione disciplinare del CSM, che è un organo del tutto sconosciuto alla Costituzione;
3) le sentenze dell’Alta Corte sono appellabili, per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte ma le sentenze della Sezione disciplinare del CSM sono del tutto inappellabili.
Come si accennava all’inizio, quello formulabile allo stato, senza avere contezza di come l’Alta Corte e le sue funzioni verranno più specificamente e concretamente conformate dal legislatore ordinario, non può che essere un giudizio provvisorio e con riserva.
Il varo della Riforma, nel caso i “SÌ” prevalessero sui “NO”, potrà essere l’occasione per una più profonda e corretta rimodulazione del sistema disciplinare riguardante i magistrati.
In questa prospettiva, possono formularsi vari auspici per l’eventuale futura sede attuativa.
Innanzi tutto, sarebbe opportuno che la legge esplicitasse formalmente la possibilità di ricorso in Cassazione, per soli motivi di legittimità, contro le sentenze dell’Alta Corte.
Inoltre, al fine di attribuire piena effettività al principio del doppio grado di merito, occorrerebbe la previsione di una distribuzione separata dei componenti dell’Alta Corte tra il primo e il secondo grado, con alcuni componenti assegnati solo al primo grado e altri, tra i quali il Presidente della Corte, al solo appello.
Sarebbe altamente auspicabile, infine, che l’attuazione della Riforma costituisse l’occasione per restituire la funzione disciplinare alla sua natura prettamente amministrativa, attribuendo ai due CSM il compito di esercitarla mediante procedimenti amministrativi ad ampio contraddittorio, sfocianti in provvedimenti (disciplinari) amministrativi, come naturalmente avviene in tutti i settori del pubblico impiego, impugnabili dinanzi all’Alta Corte.
Tale soluzione, oltre a costituire la struttura naturale della funzione disciplinare, non appare minimamente in contrasto col testo della Riforma, il quale correttamente attribuisce all’Alta Corte la giurisdizione disciplinare, lasciando impregiudicata la possibilità che la funzione disciplinare, in sede amministrativa, resti ancorata all’esercizio da parte dell’organo di autogoverno.









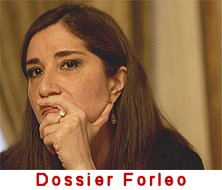








0 commenti:
Posta un commento